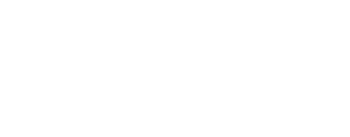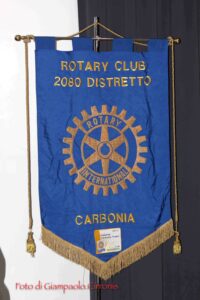L’Iglesias riparte da Giampaolo Murru in panchina, Fabricio Alvarenga e Nicolas Capellino
Archiviata con soddisfazione il campionato 2024/2025 con il quinto posto finale che non è valso la partecipazione ai playoff promozione solo per l’eccessivo divario con la seconda posizione occupata dal Monastir, poi promosso in serie D nei playoff nazionali, l’Iglesias ha deciso di ripartire da Giampaolo Murru in panchina e da due colonne della squadra, gli argentini Fabricio Alvarenga e Nicolas Capellino.
La società guidata dal presidente Giorgio Ciccu ha avviato da diverse settimane i contatti per l’acquisizione di nuovi calciatori, chiamati a sostituire i partenti, tra i quali ci sono il capitano delle ultime tre stagioni, Gianluigi Illario, accasatosi al Villasimius, Mattia Pitzalis, Santiago Brailly e Sasha Giorgetti. I nuovi già ufficializzati sono due, entrambi in arrivo dal neopromosso Monastir: il centrocampista Fabrizio Frau, classe 1995, e l’esterno sinistro difensivo Tomaso Arzu, classe 2003.
Tra i confermati, oltre a Fabricio Alvarenga e Nicolas Capellino (che dividerà il suo impegno da calciatore con quello di allenatore della squadra Under 19), ci sono i difensori Lorenzo Mechetti e Stefano Crivellaro, i centrocampisti Edoardo Piras e Alberto Piras, l’attaccante Antonny Cancilieri. Nei prossimi giorni il presidente Giorgio Ciccu dovrebbe annunciare altri nuovi arrivi. La linea scelta è quella di tesserare un maggior numero di calciatori italiani e, soprattutto, di abbassare l’età media, con diversi giovani, anche al di là del reinserimento della norma che prevede l’impiego obbligatorio in campo di almeno due fuoriquota, uno del 2006 e uno del 2007.
Giampaolo Cirronis