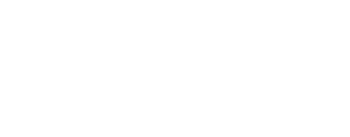Prende il via venerdì 2 dicembre la terza edizione del Cagliari film festival.
[bing_translator]
Con l’inaugurazione della mostra Exodus, del fotografo ungherese Attila Kleb, domani, venerdì 2 dicembre, alle 10.30 prende il via la terza edizione del Cagliari film festival, tre giorni di appuntamenti organizzati per vedere, in prima regionale, numerosi lavori che solitamente non entrano nelle sale cinematografiche, ma anche per scoprire i giovani autori e le giovani autrici, sardi/e e non.
La mostra di Attila Kleb è un percorso in 32 fotografie che catturano gli sguardi dei migranti ospiti del campo profughi sorto ai margini di Budapest nell’agosto 2015. L’esposizione, organizzata in collaborazione con l’associazione NoArte di San Sperate, a marzo è stata presentata nello stesso Paese- Museo da Pinuccio Sciola.
Alle 11.00 si prosegue con un’intera sezione dedicata ai corti sulle tematiche ambientali proposti dalla Fondazione Sardegna film commission (sarà presente la direttrice Nevina Satta) all’interno del progetto Heroes 20.20.20. Celebrating Sardegna “The sustainable Endless island”. Sono in programma proiezioni e incontri con alcuni autori e autrici dei corti City of Eden e The colour of energy di Gemma Lynch; Sardinia green trip di Andrea Mura, Piccoli grandi eroi di Giorgia Soi, S’istentu di Nicola Contini, UBM in Cagliari di Marilisa Piga, e Sulla rotta verde di Silvia Perra, autrice reduce dall’ultimo Torino film festival.
Alle 17.30 si apre la sezione Scenari sardi, con proiezioni e incontri con gli autori. Sarà presentato il documentario “Cagliari 1943 memorie di uno sfollamento”, firmato da Stefano Sernagiotto su un’idea dello storico dell’età moderna Giampaolo Salice. Attraverso un minuzioso lavoro di ricerca archivistica e numerose interviste il film ricostruisce lo sfollamento del capoluogo sardo durante l’ultima Guerra. Alle 18.30 è la volta di un altro documentario dedicato alla cultura hip-hop nell’isola: “Ca4arts- quattro arti una sola strada. Hip hop” di Roberto Pili. Chiude questo spazio il delicato lavoro “Armenia dimenticata”, di Ignazio Mascia, da tempo impegnato in azioni di volontariato internazionale.
Alle 21.00, per la sezione Anteprime CFF, si parla d’amore con “Oggi insieme domani anche” (Italia, 2015, 85’), documentario curato da Antonietta De Lillo, regista amatissima da critica e pubblico, rimasta nel cuore degli italiani per il suo ritratto ad Alda Merini tracciato con il film. “Oggi insieme domani anche” è un lavoro partecipato che mette insieme volti, storie, sguardi raccolti in giro per l’Italia da numerosi autori, per raccontare come sono cambiati i rapporti d’amore nel Belpaese, mirabilmente ricomposti in questo mosaico dalla De Lillo, che del progetto è anche ideatrice. Il film è introdotto da Pia Brancadori del Circola del cinema Alice Guy.
La prima giornata del CFF si chiude alle 23.00 con un progetto di ibridazione dedicato a linguaggi diversi: sarà proposto il cine-concerto “L’Age D’or”, un evento musicale curato dalle associazioni No Mos e Spazio musica, che rende omaggio a Luis Buñuel, con la proiezione delle immagini dell’omonimo film del regista spagnolo.
L’ingresso a ciascuna serata è di 3,00 euro – 1,00 euro la tessera FICC, facoltativa.