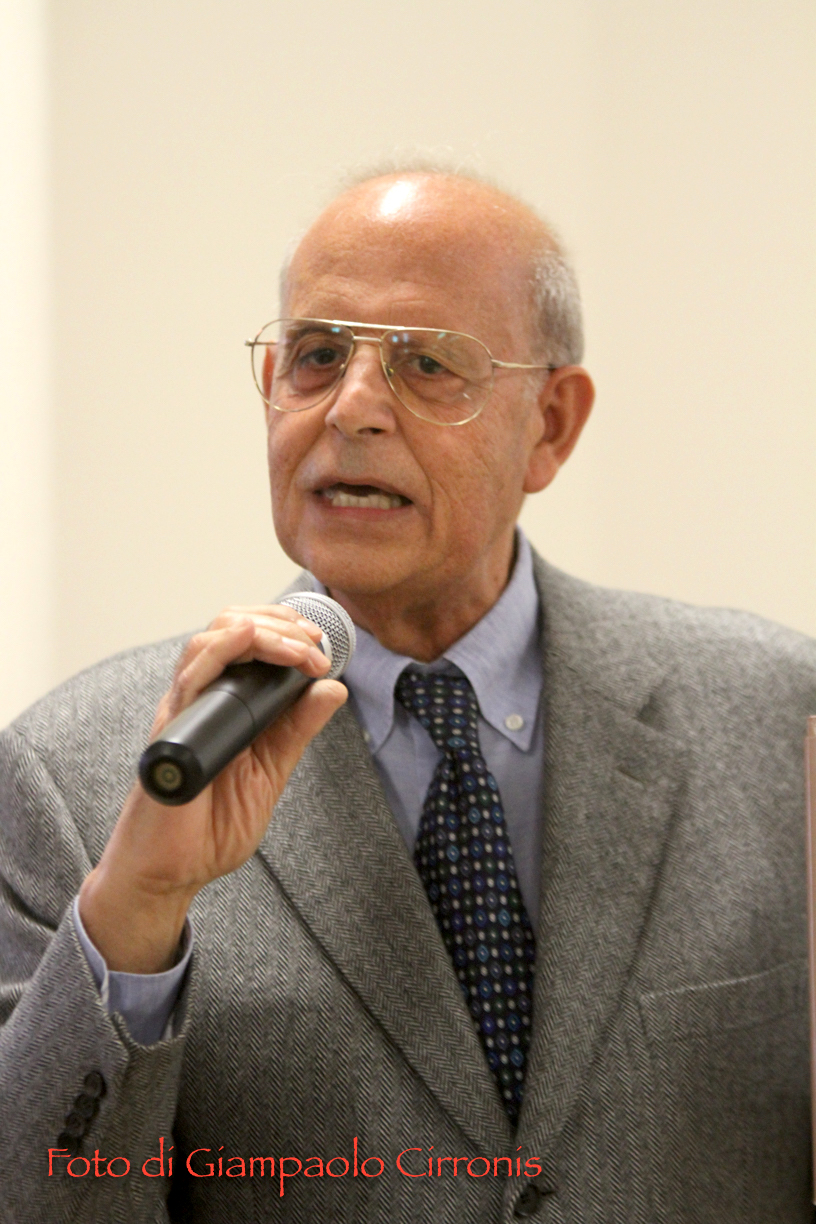“Tzia Maria” e il ministro della Sanità – di Mario Marroccu
Tutti hanno memoria di una qualche “Tzia Maria” e della sua bottega vicino a casa. Aveva due caratteristiche:
1 – Tutti potevano acquistarvi , subito e a poco prezzo, pane, pasta, conserve, Olà, DDT e saponi.
2 – Con i soldi guadagnati, “Tzia Maria” vestiva in figli, li faceva studiare, curava il marito, pagava il macellaio, il muratore, il falegname, il sarto, comprava miscela per la motocarrozzella e se ne restavano, li metteva nel libretto postale.
Erano soldi benedetti che, in un circuito virtuoso, alimentavano l’economia locale facendo lavorare anche altri artigiani. Era una “Catena di Sant’Antonio” che nutriva le città di un’economia circolare auto-prodotta.
Oggi quel tipo di economia auto-prodotta è superata. Compriamo tutto ai Super-Store: dal pane alla frutta, dalle scarpe ai vestiti, dagli infissi già pronti alle auto, etc… e i soldi finiscono immediatamente in conti correnti del Continente o all’Estero. La virtuosa economia circolare è stata sostituita da un’idrovora quotidiana che prosciuga dal danaro liquido le città. Al contrario dell’economia di “tzia Maria”, la redistribuzione del danaro è stata sostituita da un fiume in fuoriuscita unidirezionale, senza ritorno. Le conseguenze sono desolanti. Il nuovo quadro economico è ben rappresentato dal tipico aspetto assunto dai centri-città: negozi chiusi, palazzi disabitati, un corteo di cartelli “vendesi” affisso alla porta di ex locali commerciali e abitazioni. Tutti segni di impoverimento economico e di spopolamento.
Una delle cause è attribuibile all’accentramento delle attività economiche nei Super-Store: strutture nate per vendere ma che difficilmente reinvestono il ricavato nel luogo che le ospita.
Un fenomeno esattamente identico è avvenuto alla rete sanitaria locale che una volta ci forniva tutta l’assistenza sanitaria che abbisognava. Le nostre Province, con i loro ospedali e le loro reti territoriali sanitarie erano totalmente autonome nell’auto-prodursi il Servizio sanitario in medici, personale, strumenti e edifici proprii. Ricordiamo che le Università istruiscono i Medici ma non li formano professionalmente. La loro formazione professionale è avvenuta sempre negli Ospedali, ad opera dei primari e dei medici anziani. Una legge dello Stato, la 128/69, all’articolo 7, imponeva l’obbligo ai primari di formare culturalmente e professionalmente i nuovi medici. Così i nostri ospedali auto-producevano le nuove generazioni di medici bene addestrati. Qui si curavano le malattie internistiche dei bambini e degli adulti, si facevano gastroscopie, colonscopie, TAC ed esami di laboratorio, si operavano tutte le patologie addominali, toraciche, ortopediche, urologiche, ginecologiche, traumatologiche, e qui si nasceva in sicurezza. Tutti erano nelle condizioni di apprendere l’arte medica, a fare gli elettrocardiogrammi, le colonscopie e ad operare. Nonostante in quei tempi i medici fossero numericamente in numero inferiore rispetto ad oggi, non esisteva il problema della carenza di medici e le liste d’attesa si esaurivano in giornata o in una settimana. Il mondo poi è cambiato.
Fino al 1978 gli ospedali provinciali erano finanziati dai proventi provenienti dalle Casse mutue private e dai privati cittadini. In quell’anno Tina Anselmi abolì le Casse mutue e creò il Fondo sanitario Nazionale. Da quell’anno la Sanità fu veramente e totalmente pubblica. Lo Stato, su proposta di Tina Anselmi, istituì il Servizio sanitario nazionale (L. 833/78), diede in gestione le USL territoriali ai sindaci e ai Consigli comunali. Furono applicate esattamente le norme costituzionali che suddividono gli Enti gestori dei servizi pubblici in: Comuni, Province, Regioni.
Era chiaro che, in democrazia, la gestione pubblica spettasse al popolo tramite i suoi rappresentanti. Tina Anselmi era un personaggio complesso: proveniva da una famiglia socialista; da universitaria nel 1944 vide impiccare dai nazisti i 31 martiri di Bassano del Grappa e aderì immediatamente alle brigate partigiane combattenti in montagna. Lì, nei bivacchi, si discuteva sul come costruire la Costituzione del nuovo Stato che avrebbero creato. Fu attiva nella CGIL e poi aderì ad uno dei tre partiti che scrissero la Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Per effetto dell’articolo 3 della Costituzione, che conferiva pari diritti a maschi e femmine, poté essere candidata; nel 1956 divenne deputato della Repubblica e scrisse il testo della legge sulla “pari opportunità” Uomo-Donna. Fu il primo ministro donna nella storia italiana. Nel 1976 venne nominata ministro della Sanità e scrisse il rivoluzionario testo di Riforma sanitaria: la legge 833/78. In quasi tutte le Regioni la nuova legge di riforma venne compiutamente applicata nel 1982. Fu un’esplosione di democrazia. Durò fino al 1992 e fu il decennio d’oro della Sanità italiana. Gli ospedali crebbero di numero e in qualità. Gli amministratori locali misero in competizione le USL fra di esse. In quella gara ognuno si assicurava i migliori professionisti per dirigere i reparti e iniziò la produzione, in ciascuna provincia, di una Sanità autoctona, auto-prodotta, adeguata alle esigenze di ciascun territorio nel rispetto delle norme nazionali.
La Sanità divenne un motore economico che, attirando pazienti e finanziamenti, produsse profitto per la comunità, così come oggi lo producono il Turismo, la Cultura, e l’Archeologia. Poi venne l’anno 1992 ed entrammo in un trentennio molto controverso.
Oggi sappiamo che in quell’anno avvenne la fine dell’entusiasmo creativo dei partiti politici e della partecipazione popolare. Fu l’anno di Mario Chiesa, di “tangentopoli” e dello sconquasso dei partiti dei Padri costituenti. In quell’anno, alle dimissioni di Francesco Cossiga da Presidente della Repubblica, venne proposta la candidatura di Tina Anselmi. Se fosse stata nominata lei come Presidente, avrebbe sicuramente protetto la sua legge di Riforma sanitaria. Viceversa, venne eletto Oscar Luigi Scalfaro, il quale nominò ministro della Sanità il rappresentante del Partito liberale, on. Francesco De Lorenzo. La storia della Sanità pubblica cambiò.
Francesco De Lorenzo proveniva da una parte politica che non aveva partecipato alla scrittura della Costituzione. Conformemente alle sue idee economiche, agli antipodi di quelle di Tina Anselmi, egli produsse una sua “Riforma sanitaria”, la L. 502/92, in cui applicò il concetto di “impresa” alla Sanità pubblica. Rimosse i sindaci e i Comitati di gestione. Le Unità Sanitarie Locali (USL) presero il nome di “Aziende Sanitarie Locali” e per dirigerle egli inventò la figura del “Manager”. E’ una figura tipica delle imprese economiche basate sulle regole del mercato privato. Il centro dell’attenzione, che prima era il “cittadino malato”, divenne “l’Ufficio del bilancio”. Alla direzione “democratica” si sostituì la direzione “centralizzata”. Da allora il metodo più semplice di ridurre la spesa sanitaria consiste nello spendere il meno possibile e nel “centralizzare”, quindi: meno personale, meno strumenti, meno accessibilità alle cure. Ai politici di allora sfuggì che esiste uno stretto connubio tra la democrazia, il benessere dei cittadini e la loro percezione di sicurezza. E’ per questo che i cittadini amano le libere elezioni: perché incentivano i Governi a tutelare il benessere. A queste disattenzioni consegue in genere la caduta del consenso popolare. A quel primo atto di centralizzazione del potere in un’unica Persona-Manager sono poi seguite altre “centralizzazioni”. I politici locali allora perdettero il potere di controllo sulla Sanità pubblica. Oggi lo stanno perdendo i politici regionali: la centralizzazione del controllo della Sanità regionale è stata acquisita da un’altra struttura gestionale, al di fuori dell’assessorato della Sanità, a cui è stato conferito grande potere ed autonomia. Tale nuova struttura, l’ARES, seguendo una logica amministrativamente ineccepibile e in linea col processo di aziendalizzazione dell’intera struttura sanitaria sarda, ha proceduto alla “delocalizzazione” di fatto dell’assistenza sanitaria, trasferendola dalle Province al centro della Regione. Il cambiamento è enorme.
L’impoverimento dell’apparato ospedaliero provinciale oggi impone che i nostri “corpi malati” vengano forzatamente trasferiti negli ospedali DEA di II livello di Cagliari e negli ospedali universitari per qualunque malattia, sia grande sia piccola. Tale centralizzazione sta comportando la scomparsa degli ospedali DEA di I livello, che sono gli 8 ospedali provinciali delle 8 province sarde. La conseguenza è tutti i giorni nelle prime pagine dei quotidiani. Gli ospedali cagliaritani, sommersi da un eccesso di richieste di cure provenienti da tutta la Regione, sono finiti in scompenso funzionale. In certi momenti si è rischiata la chiusura per impossibilità di accettare altri pazienti.
Certamente la soluzione non consiste nel tornare ai tempi di “tzia Maria”. Si potrebbe però applicare correttamente la legge sulla “Rete Ospedaliera Regionale” del 2017, rimasta nel cassetto.
Si potrebbe anche riportare al controllo delle ASL i sindaci del territorio, che potrebbero affiancare con funzione di proposta e controllo, i Manager.
Potremmo avere la gradita sorpresa di restituire la certezza delle cure alle Province e, forse, di innescare anche un sano circuito di ritorno economico.
Mario Marroccu